Welcome To The Blackout… e Bowie divenne il Duca Bianco
Un live inedito di grande qualità racconta i concerti londinesi di David Bowie a fine anni ’70
Diciamolo subito, la pubblicazione di Welcome To The Blackout (Live London ’78), l’ennesimo live inedito di David Bowie, immortalato dal vivo – come già nel classico Stage – nei celebri panni del Duca Bianco, è senz’altro una speculazione commerciale nel segno della nostalgia. E non a caso l’album è stato rilasciato in occasione del Record Store Day 2018.

Nel dire questo non crediamo di far torto alla memoria della grandissima star inglese e ai tantissimi che coltivano questa memoria con una dedizione prossima al fanatismo: lo stesso Bowie, da buon allievo di Andy Warhol, fu sempre molto attento all’impatto pubblico, quindi anche commerciale, della sua musica senza tuttavia sacrificare l’aspetto artistico a favore dei numeri (la qualità per la quantità, insomma) e, bravo amministratore di sé stesso, fu il primo a speculare sulla propria attività.
Ciò chiarito, è doveroso aggiungere che quest’operazione, gestita direttamente dalla Parlophone, ha un grosso valore filologico (già, ormai è doveroso accostarsi a un classico come Bowie nei termini della filologia): l’album, registrato dallo storico produttore Tony Visconti, documenta la parte britannica dell’Isolar II tour, svoltasi a partire dal giugno ’78, che segue i concerti americani della primavera di quello stesso anno, da cui è tratto il menzionato Stage.

I nastri, mixati l’anno successivo dal Duca in persona, sarebbero dovuti diventare la colonna sonora di un docufilm girato da David Hemmings (sì, avete capito: il protagonista di Blow Up e Profondo Rosso), ma rimasto tra le opere incompiute della storia del rock.
Non è il caso di arrovellarsi troppo in ipotesi sulla mancata realizzazione della pellicola, ma limitiamoci a riflettere sulla qualità del materiale riesumato per rispondere alla domanda che può sorgere spontanea: Welcome To The Blackout è roba per fan o può essere fruito senza problemi anche dai semplici estimatori di Bowie e, più in generale, del rock classico? L’alto livello sonoro delle incisioni rende il doppio cd utile a entrambi: agli ultrafan, perché documenta il periodo più delicato della carriera del loro beniamino; a tutti gli altri, perché racconta non solo la trasformazione di Bowie, ma anche i mutamenti del rock, che cambia le sue sonorità e si proietta pian piano verso l’elettronica che avrebbe imperversato nel decennio successivo. Altra, e più delicata questione è quella relativa al peso dell’esperienza berlinese di Bowie, a cui parteciparono mostri sacri del livello di Robert Fripp e Brian Eno, sulle correnti musicali più all’avenguardia degli ’80. Non è il caso di rispondere, sebbene non si possa far finta di notare che quell’uso particolare delle chitarre e dell’elettronica rielaborate in maniera paricolarissima e il cantato baritonale pieno di chiaroscuri, che prende il posto dello stile urlato tipicamente settantiano, partono da Bowie o in lui ebbero un precursore imprescindibile.

Torniamo all’album, che si basa sulla scaletta originale dei tour riproposta praticamente tal quale (a differenza di Stage, la cui tracklist originale era alterata e sarebbe stata rimessa a posto solo nell’edizione del 2005): il Duca appare in formissima, accompagnato sul palco da una delle migliori rockband di sempre.
I due chitarristi – lo sperimentale e bizzarro Adrian Belew, approdato alla corte di Bowie dalla factory di Zappa e prossimo all’ingresso nella nuova reincarnazione dei King Crimson e lo squadrato ma passionale Carlos Alomar – l’enigmatico bassista George Murray, il virtuoso batterista Dennis Davis, formatosi nel jazz e approdato, proprio grazie a Bowie e assieme ad Alomar, alla scena rock, i due tastieristi d’avanguardia Roger Powell e Sean Mayes e il violinista elettrico Simon House, uno dei protagonisti più oscuri della scena prog, sono amalgamati alla perfezione e danno vita a una serie di arrangiamenti pieni di eclettismo e creatività. Intendiamoci: nulla che Stage non documenti già. Ma Welcome To The Blackout ha qualcosa in più in genuinità, visto che non ha subito le manipolazioni del suo predecessore.

Inutile analizzare la tracklist pezzo per pezzo, perché le esecuzioni sono simili a Stage (d’altronde Bowie era amante del controllo e non amava troppo improvvisare): ci limitiamo a dire che, rispetto al live americano, ci sono due brani in più: Sound And Vision e Rebel Rebel, resa in una versione rallentata e dilatata rispetto all’originale.
In formissima nella resa dei brani berlinesi, la band segna un po’ il passo nelle canzoni dell’era Ziggy (Five Years, Soul Love, in cui si segnala il fantastico assolo al moog di Powell, Star, Hang On To Yourself, Ziggy Stardust, un po’ troppo annacquata dall’elettronica, e Suffragette City). Colpa della stanchezza, senz’altro avvertita da Bowie, di ripetere i brani della fase più turbolenta della sua carriera? Probabilmente.
Ma con altrettanta probabilità avrà pesato non poco la difficoltà di rendere in chiave art arrangiamenti e interpretazioni concepiti per un altro contesto. Rispetto a Ziggy, il Duca Bianco urla poco e preferisce le eleganti tonalità baritonali ai falsetti e la superband che si porta appresso è meno incline a eccedere rispetto agli Spiders From Mars.
Welcome To The Blackout è un esempio eccellente di rivalutazione e rilancio postumi di materiali inediti, segno che, a differenza di quel che è capitato ad altri illustri scomparsi del rock (Jimi Hendrix e Jim Morrison), celebrati con la pubblicazione di materiali discutibili (spesso scarti di studio, che dovevano restare tali), per la figura di Bowie c’è un forte rispetto.
Sempre a proposito di celebrazioni: non sarebbe il caso, a questo punto, di recuperare anche le pellicole girate da Hemmings per regalare al popolo del rock altre forti, sane emozioni? Anche questa sarebbe una speculazione, ci mancherebbe. Ma se le speculazioni sono queste…
Per saperne di più:
Il sito web ufficiale di David Bowie
Da ascoltare (e da vedere):
12,808 total views, 10 views today



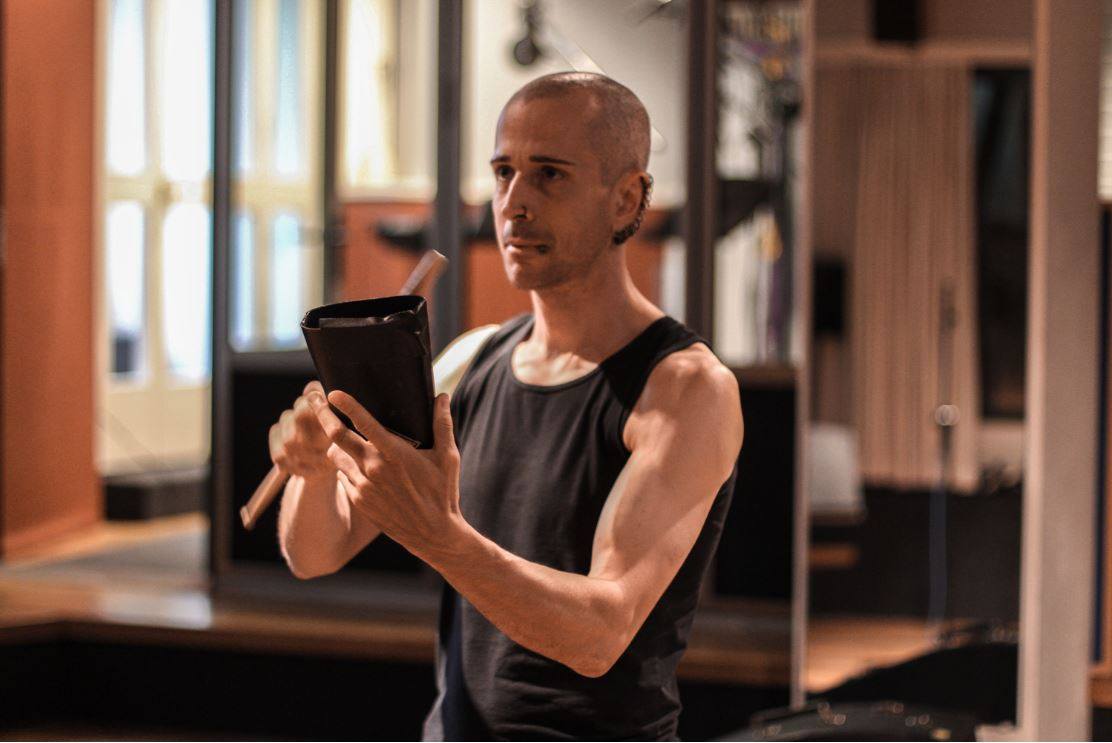
Comments