I giornali online? Finalmente come tutti gli altri
Secondo la V Sezione penale della Cassazione il direttore di un giornale online ha le stesse responsabilità dei suoi colleghi della carta. Un ulteriore passo in avanti verso la completa parificazione. Ma l’ultima parola spetta al legislatore…
La V Sezione penale della Cassazione ha affondato ancora una volta il bisturi nel mondo complicato del giornalismo online, che sta soppiantando pian piano quello tradizionale, sebbene il legislatore ancora stenti ad accorgersene.
Lo ha fatto con la recente sentenza 1275 pubblicata l’11 gennaio 2019, con cui stabilisce in maniera equivocabile che l’articolo 57 del Codice penale si applica anche al direttore di una testata online registrata.

Era ora: i giornali online sono uguali a quelli cartacei e fanno le stesse cose. Anzi, di più, perché il web non si ferma alle edicole e non va al macero o, come si diceva una volta, non finisce a incartare il pesce o l’insalata.
Per capire di cosa si parla, è opportuno citare per esteso l’articolo 57:
«Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».
Questa norma definisce la responsabilità del direttore nell’esercizio dei suoi poteri. Anzi, di fatto dà un fondamento rigoroso al potere del direttore, proprio perché ne definisce la responsabilità.

A rigore questa sentenza non dovrebbe fare notizia: il direttore dirige (o dovrebbe farlo) sempre, sia su carta sia su bit. Fa notizia, semmai, che di questo fatto banale si siano dovuti accorgere la magistratura, tra l’altro con un ritardo considerevole rispetto all’esplosione del giornalismo online.
Colpa del legislatore, si è già detto. Ma probabilmente anche colpa della categoria professionale dei giornalisti e di quella imprenditoriale degli editori: nessuna delle due, a quel che se ne sa, ha mai espresso una linea unitaria o un’istanza forte sull’argomento.
Anche per motivi intuibili: aprire spazi al giornalismo digitale a scapito di quello analogico (cartaceo o televisivo), approfittando magari dei vantaggi offerti da questa disparità di trattamento, per cui chi dirige un web magazine con milioni di lettori potenziali ha meno responsabilità penali rispetto a chi dirige un quotidiano o un settimanale che se raggiunge diecimila persone è grasso che cola.

Infatti è questa la conclusione a cui si dovrebbe giungere sulla base della normativa, ormai ridotta al caos, tra leggi vecchie come il cucco e miniriforme di settore che sembrano il classico abito di Arlecchino.
Il tutto, con un danno serio per tutti gli operatori dell’informazione, che come al solito lottano con un sistema poco garantista anche per la mancanza di regole certe per tutti.
Per capire meglio, è opportuno fare il classico passo indietro e capire cosa c’era prima di questa sentenza.

Nell’ambito legislativo, poco o niente: il primo tentativo di normare il giornalismo online è piuttosto tardivo e risale a inizio millennio. Per la precisione alla legge 62 del 21 marzo 2001, che a sua volta modificava la legge sull’editoria, la 416 del 1981.
Nell’articolo 1 della legge 62 si apprende che:
«Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici».
Ma tra prodotto editoriale e giornale c’è ancora una differenza, visto che il giornale è un prodotto editoriale ma non il prodotto editoriale in sé.
La lacuna è colmata dal comma 3 dello stesso articolo, che stabilisce in maniera inequivocabile che:
«Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948».
Il balzo all’indietro è notevole: la 62 rimanda alla vecchia legge sulla stampa, che impone la pubblicazione della gerenza, cioè di indicare la proprietà, l’editore e la sede del prodotto editoriale e, nel caso di pubblicazioni periodiche, anche il direttore responsabile.
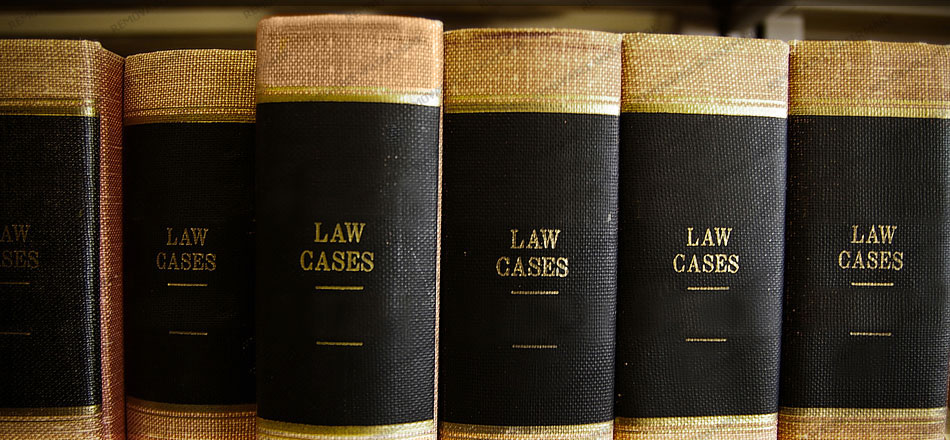
A questo punto occorre chiedersi: al balzo all’indietro corrisponde un passo in avanti? Cioè, si è fatta qualcosa perché chi gestisce un giornale online abbia le stesse responsabilità di chi pubblica un giornale di carta? La risposta è no.
L’intoppo è nell’espressione «ai fini della presente legge» che, tradotta in soldoni (e non è solo un modo di dire), significa: ai fini dell’applicazione del regime delle agevolazioni e delle sovvenzioni pubbliche. Con un risultato non bellissmo: un giornale online può prendere le stesse sovvenzioni di quelli cartacei, fruire allo stesso modo delle agevolazioni fiscali e di tutti gli altri benefit. Ma il suo direttore non passa gli stessi guai dei suoi colleghi che lavorano in analogico, i quali devono anche fare i conti con costi industriali (tipografici ecc.) decisamente maggiori.
Ma questa disparità di trattamento è anche l’esito di un sistema giuridico non proprio aggiornato. Già: mentre negli altri settori (quello civile e amministrativo) si può andare avanti a botte di interpretazione, in quello penale è obbligatorio che la legge indichi le responsabilità e i magistrati possono colmare le lacune solo a botte di virtuosismi. E si sa: più è ardito il virtuosismo, più è facile prendere la stecca.

E il fatto che una lacuna da colmare ci sia, lo prova il fatto che da circa quindici anni giace in Senato, tra i vari, il disegno di legge 3176 del 2004, che, appunto, mira ad estendere l’articolo 57 del Codice penale al direttore dei giornali online.
Ma c’è da dire che non tutti i magistrati la pensano allo stesso modo. Non a caso, su questo argomento si sono formati due partiti.
Il primo, più conservatore, si è basato sulla normativa esistente e escluso a lungo la comparazione tra direttori analogici e digitali, ed è prevalso almeno fino al 2010.
Il secondo, più progressista, ispirato dalla convinzione che le leggi possano (e debbano) essere interpretate per evitare ingiustizie, ha iniziato a prevalere dal 2015.
L’oggetto del contendere è la nozione di stampa, così come contemplata dall’articolo 1 della legge 47 del 1948, che è il caso di citare per intero perché è lo scoglio di tutto l’argomento:
«Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione».

Per il legislatore del 1948 la stampa era ferma a Gutenberg. In questo non c’è nulla di strano, perché la tecnologia disponibile era davvero il filo a piombo, la linotype e la stampa a caldo. Un altro mondo. Ma il problema è che questa è l’unica nozione legale disponibile di stampa, oltre la quale è difficile che chi applica la legge possa andare.
Infatti, il primo problema si è posto per i direttori delle radio e delle televisioni: perché anche a loro fosse esteso l’articolo 57 c’è voluta la legge 223 del 1990.
Ma il resto della normativa è stata finora molto più favorevole al web rispetto agli altri media. Così, ad esempio, la legge 70 del 2003 esclude la responsabilità dei provider per gli eventuali contenuti diffamatori diffusi in rete e, quindi, anche quella dei coordinatori di forum, newsletter e blog. In pratica, il reato lo paga solo chi lo fa e non anche chi non glielo impedisce. A paradosso si aggiunge paradosso: mentre il tipografo può essere responsabile di quel che stampa, il proprietario di un server no. Mentre il direttore di un giornale è senz’altro responsabile, il titolare di un blog no, perché il reato è solo di chi materialmente (scrivendo o con l’audio o il video) lo fa.
E allora non ci si deve meravigliare se nel 2010 la V sezione penale della Cassazione, sulla base di questo disordine normativo, aveva annullato, con la sentenza 35511, la condanna inflitta al direttore di un giornale online.

Più che giustizia, fu un garantismo eccessivo, che accentuava la disparità nei confronti dei direttori degli altri media. E se l’indirizzo fosse rimasto questo, i paradossi sarebbero aumentati.
Magari sulla scia della strategia editoriale de Il Fatto Quotidiano, che esiste con due testate, una cartacea e un’altra online, ciascuna col suo direttore. Inutile dire che la versione telematica, usata come rompighiaccio, è stata a lungo più aggressiva (con tanto di contenuti espliciti a sfondo sessuale) rispetto a quella, già tosta di suo, destinata alle edicole. Stesso editore, stesso corpo giornalistico, stesso nome, ma redazioni diverse. Tanto basta a introdurre una disparità di trattamento nello stesso soggetto. Più che ingiustizia è schizofrenia.
Il partito progressista ha iniziato la sua rimonta con la sentenza 31022 del 23 luglio 2015 con cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno aggirato per la prima volta lo scoglio della legge del ’48 e hanno equiparato a livello di responsabilità penale le testate digitali a quelle cartacee.

La decisione, in questo caso, mirava a garantire le testate online registrate dai loro competitor immediati: cioè i blog, i siti normali e le bacheche dei social. In pratica, gli ermellini hanno stabilito che solo ai giornali online possono applicarsi le garanzie previste dall’articolo 21 della Costituzione nel caso di sequestro, proprio come accade coi media analogici. Per tutti gli altri no.
Detto altrimenti: la Suprema Corte ha scongiurato l’ingiustizia che derivava dalla possibilità di oscurare un sito professionale di informazione (e tali sono i giornali online regolarmente registrati) con la stessa facilità con cui si può oscurare un sito pedopornografico, un blog pieno di insulti gratuiti o altre pagine estreme.
Non potendo abbattere del tutto lo scoglio costituito dal fatto che per stampa il legislatore intende la tipografia gutenberghiana, i magistrati hanno fatto leva su un altro concetto: la testata, che sottintende un’organizzazione di tipo giornalistico con le relative gerarchie.

La sostanza, insomma, ha avuto la meglio sulla tecnica. E la sentenza 1275 del 2019, prosegue su questa linea, anche sulla base del principio che laddove ci sono maggiori garanzie ci devono essere maggiori responsabilità.
Certo, anche questa scelta (giustificata con la finezza giuridica della interpretazione estensiva ed evolutiva) è stata aspramente criticata. Tuttavia, la strada è tracciata, perché gli addetti ai lavori (e chi più addetto ai lavori della magistratura di vertice?) si sono accorti che l’informazione è cambiata e la giustizia deve adeguarsi, proprio per evitare che l’informazione online diventi un Far West in cui vincono i più prepotenti e i più volgari. Ora se ne deve accorgere solo il legislatore. Ma, ci si passi la considerazione, è difficile che possa farlo quello attuale, arrivato al successo politico a botte di propaganda scorretta, fake news e amenità varie, tutte benedette dall’anarchia della rete.
67,970 total views, 2 views today




Comments