La guerra per il Mezzogiorno, i dieci anni tragici del Sud risorgimentale
Nel suo recente saggio, Carmine Pinto fa il punto sul brigantaggio e sulla guerra civile borbonica contro l’Unità d’Italia. Il prof di Salerno ha pochi dubbi: fu un fenomeno criminale di massa, motivato dal disagio e sobillato dagli ex re in esilio a Roma. Una lettura rigorosa che manda in soffitto Gramsci e e archivia, si spera definitivamente, una certa mitologia del “bandito sociale”
Un best seller con dati imponenti, a dispetto della mole (quasi cinquecento pagine) e dell’argomento non facile.
La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860-1870 (Laterza, Bari 2019), uno studio completo e poderoso dedicato da Carmine Pinto al Sud postunitario, ha esaurito lo stock in poco tempo ed è ai primi posti della classifica di vendite del suo editore.

Un successo meritato, che fa capire due cose.
Innanzitutto: non esistono argomenti difficili o noiosi ma solo modi difficili e noiosi di trattare gli argomenti.
In secondo luogo: se un argomento interessa, non ci sono complessità che tengano.
Al riguardo, va messo subito in evidenza che Pinto è riuscito a compiere un’operazione notevole, in cui si combinano felicemente il rigore accademico (l’autore è docente ordinario di Storia contemporanea all’Università di Salerno) e la chiarezza di linguaggio e a porre in una prospettiva nuova i problemi sollevati in sede storiografica dal brigantaggio.
A questo punto è necessario un chiarimento: La guerra per il Mezzogiorno non è un libro sul brigantaggio, anche se tratta moltissimo di briganti sulla base di una documentazione vastissima.
Il saggio di Pinto, semmai, inserisce i briganti, le loro gesta e le loro (tantissime) malefatte nel quadro più complesso delle lotte furibonde nel Mezzogiorno continentale che seguirono l’unificazione nazionale. Di queste lotte, il brigantaggio fu senz’altro la manifestazione più cruenta, appariscente e invasiva. Ma la rilettura attenta e profonda di quelle vicende travagliate rivela che l’azione dei briganti, la quale fu endemica nel quinquennio successivo all’Unità, non assorbì l’opposizione al nuovo sistema politico, che si svolse su più livelli.

Detto altrimenti: il brigantaggio fu l’aspetto militare, tra l’altro neppure ben riuscito, di una guerra civile di ben altra complessità, in cui, ricorda Pinto nell’Introduzione, si verificò «la definitiva saldatura tra guerra italiana e conflitto civile meridionale». Perciò, sempre secondo il prof di Salerno,
«Il conflitto tra progetti nazionali, pan-italiano filo-sabaudo e autonomista napoletano borbonico, iniziato nel 1848, assorbì e portò a sintesi le antiche fratture tra liberalismo e assolutismo legittimista, fazioni e gruppi locali, rivendicazioni sociali e tradizioni di brigantaggio che per mezzo secolo avevano frammentato il regno meridionale».
Detto altrimenti, il crollo del Regno delle Due Sicilie creò una polarizzazione: di qua, con i Borbone, tutti i sostenitori dell’Ancien Règime, di là con il nuovo Regno d’Italia, i fautori del liberalismo, identificato con la causa nazionale. Difatti, precisa lo storico salernitano:
«Ai contendenti era chiaro che la nazione italiana non poteva esistere senza le province meridionali; di converso la patria borbonica era identificata univocamente con l’antico regno. Vincere, per gli unitari, significava dare vita e legittimità definitiva al nuovo edificio nazionale. Resistere, per i legittimisti o i briganti, era l’unica possibilità di sopravvivere come soggetto politico o attore sociale».
Quindi
«la guerra si riverberò anche sui civili, che ne subirono gli effetti e vi parteciparono spesso attivamente».

Fu questa guerra civile, condotta dal nuovo Stato nazionale e dalla corte borbonica in esilio nella Roma papalina, il fulcro di ciò che accadde nel decennio che iniziò con la presa di Napoli e terminò con quella di Roma.
Questa guerra civile coinvolse attori internazionali (i vertici degli Stati europei e le relative diplomazie e la Chiesa) ed ebbe ripercussioni importantissime: si pensi solo che il nuovo Stato italiano fu riconosciuto tardi da Spagna, Russia e Austria.
Da questi cenni si capisce che la lettura di Pinto, pur restando ancorata con forza alla storiografia, apre non poco alle scienze politiche. Una lettura nuova, ripetiamo. Ma nuova non vuol dire inedita, perché lo studioso campano riprende e amplia i lavori recenti di Salvatore Lupo, Renata De Lorenzo e Paolo Macry.
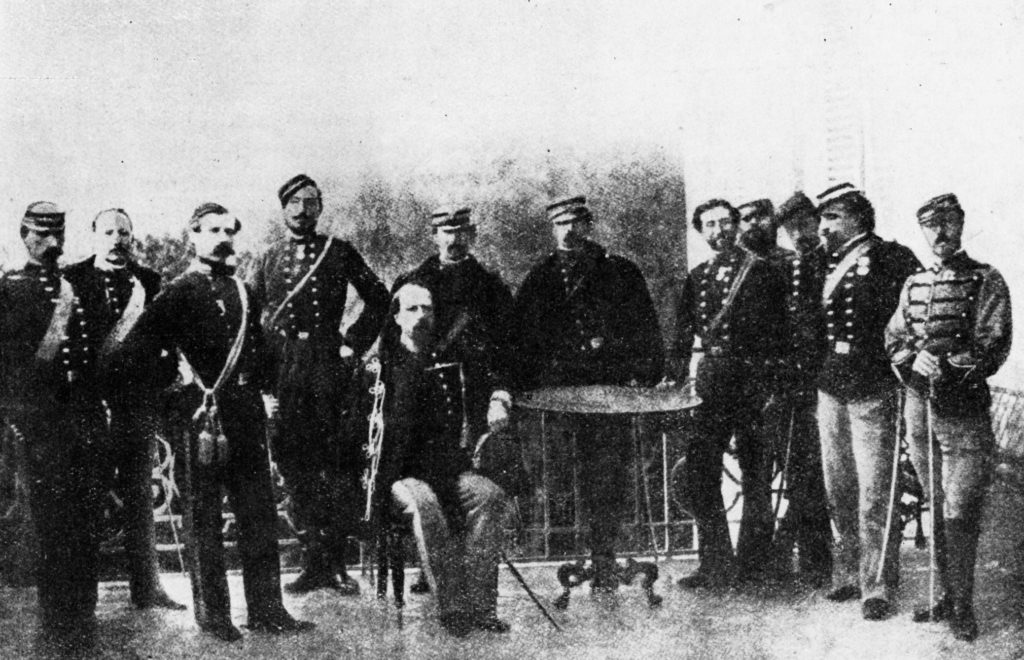
Aprire ai canoni politologici significa anche abbracciare una lettura realista e non ideologizzata, che fa piazza pulita di tante, vecchie concezioni del brigantaggio.
In altre parole, se i briganti, pur restando in primo piano (e non potrebbe essere altrimenti) non sono più i protagonisti assoluti, vengono meno altre letture che resistono tuttora.
Innanzitutto, quella di matrice gramsciana, che ha raggiunto l’apice negli studi di Franco Molfese ed è molto presente nel più recente revisionismo antirisorgimentale (ad esempio, nei libri di Gigi Di Fiore): ci si riferisce alla tesi del brigantaggio come protolotta contadina.
In seconda battuta, cade anche la tesi, nata dalla propaganda borbonica, che considera i briganti come difensori delle popolazioni meridionali, transitata quasi senza filtro dalla vecchia propaganda borbonica al neoborbonismo.

Ciò non vuol dire, ovviamente, che nel brigantaggio non siano presenti forti motivazioni sociali e politiche, perché nelle bande militarono persone motivate dal forte disagio e dalla miseria del mondo rurale del Sud ed ex militari borbonici. Significa, più semplicemente, che nessuna di queste due concezioni può assorbire il fenomeno, che non ha un senso univoco e che, se lo si scollega dalla guerra civile, resta semplicemente privo di senso.
La partita vera fu più complessa.
La corte borbonica in esilio la giocò con tutte le armi possibili (che tra l’altro non furono pochissime) di cui poteva disporre all’epoca un governo ombra: i legami con gli ambienti legittimisti europei e con la Chiesa; la propaganda martellante, che produsse una pubblicistica imponente; la diplomazia, che tentò anche qualche buon colpo per rompere l’isolamento internazionale; il consenso di cui la stessa godeva in vari strati della popolazione, di sicuro minoritari ma non per questo di nicchia.
Il Regno d’Italia, pur dotato dei non pochi mezzi di uno Stato dell’epoca, dovette invece far fronte a una serie di problemi non irrilevante: la non completa accettazione della sua esistenza a livello europeo; gli equilibri geopolitici precari che avevano consentito l’Unità ma che continuavano a pesare (si pensi al ruolo ambiguo di Napoleone III nella questione romana e al grande gioco britannico nel Mediterraneo, di cui l’Italia fu pedina sin da subito); le necessità organizzative del nuovo Stato e quelle, altrettanto pressanti, della sintesi tra le varie anime politiche protagoniste del Risorgimento.

Ciononostante, la vittoria toccò alla nuova classe politica, decisamente più radicata nella modernità e nel consenso delle popolazioni meridionali.
Torniamo ai briganti: se non furono patrioti e neppure contadini in lotta, cosa furono? Pinto dà la risposta sovrapponendo due tipi di analisi: quella delle biografie dei protagonisti del brigantaggio e quella relativa alle vittime delle bande.
Dal primo punto di vista, i numerosi precedenti penali collezionati dai principali leader (i vari Crocco, Ninco Nanco e via discorrendo), anche durante il regime borbonico, non lascia adito a dubbi: fu un fenomeno criminale di massa, inedito nella storia italiana ma non in quella del Mezzogiorno, che si politicizzò proprio in seguito alla rottura dell’ordinamento duosiciliano. Una comparazione col brigantaggio preunitario, anch’esso endemico e sanguinario, avrebbe chiarito ancor meglio questo concetto. Ma ci rendiamo conto che manca perché non funzionale all’economia del libro.
Sotto l’aspetto vittimologico, l’analisi di Pinto rivela che le vittime principali dei briganti furono principalmente gli stessi contadini ed esponenti del mondo rurale spesso soggetti a pressioni e intimidazioni di vario tipo e vittime di abusi (soprattutto, per quel che riguarda le donne, di tipo sessuale) odiosi e di crimini efferati.

La caccia al ricco, i briganti la praticarono soprattutto per finanziarsi, con metodi e risultati che ben poco hanno a che fare con esigenze di giustizia e di redistribuzione della ricchezza. Detto altrimenti, il comportamento delle bande meridionali della seconda metà dell’Ottocento ricorda non poco le gesta del banditismo sardo del secolo scorso.
Invece, per quel che riguarda l’aspetto politico, è senz’altro indubbio il ruolo delle bande contro la classe politica liberale. Però questo ruolo si diluisce non poco non appena emerge (ed emerge anche a uno scavo superficiale) l’ambiguità dei rapporti tra le bande e il notabilato locale (resta esemplare la vicenda dei Fortunato in Basilicata).
Ma è l’assenza pressoché completa dei briganti nelle questioni demaniali e nelle aspirazioni del mondo agricolo a escludere il legame con le lotte contadine, che sarebbe diventato un must dello storytelling gramsciano. Infatti, Pinto dimostra con la consueta dovizia di dati come i briganti non presero mai parte alle rivendicazioni terriere né si intromisero nelle usurpazioni demaniali e quando lo fecero agirono sempre all’interno delle rivalità e delle lotte tra notabili e proprietari.
In altre parole: è vero che l’origine umile, il disagio sociale e l’ansia di riscatto spinsero molti a militare nelle bande. Ma è altrettanto vero che da questi moventi non uscì mai un anelito rivoluzionario né quella che si sarebbe definita in seguito coscienza di classe.
La stragrande maggioranza dei briganti considerò la lotta armata come una specie di ascensore sociale, grazie anche alle promesse della corte borbonica che richiamavano nella memoria collettiva quelle fatte a inizio ottocento ai lazzari del cardinale Ruffo.
Quindi, molti si diedero al brigantaggio sia per far bottino nel presente (e quindi sottrarsi a condizioni di vita grame) sia con la speranza di un prestigio sociale futuro.
La risposta del nuovo Stato, che agli occhi odierni può sembrare eccessiva, fu in realtà proporzionata a un fenomeno pesante, per virulenza e diffusione, di cui le popolazioni furono il più delle volte spettatrici e vittime: l’invio di massicci contingenti di soldati, dei quali facevano parte non pochi meridionali, il ricorso a sistemi pesanti e la gestione militare del territorio.

La situazione totalmente inedita costrinse i vertici militari e politici del nuovo Stato a misure eccezionali: i continui stati d’assedio proclamati da Cialdini (che, essendosi formato nelle guerre carliste era un esperto di guerriglia), e poi la legislazione d’emergenza, la famigerata legge Pica, che sospese le libertà costituzionali in più zone del Mezzogiorno continentale. Il teatro in cui agirono i soldati italiani – spesso impreparati alla guerriglia feroce di cui invece i briganti erano maestri grazie anche all’aiuto di esperti militari legittimisti – fu senz’altro bellico, a dispetto dei tentativi della nuova classe dirigente di negare ai nemici lo status di belligeranti.
Alla forza tattica delle bande, che in molte occasioni riuscirono a ottenere risultati notevoli sul campo, non corrispose mai una visione strategica. E non a caso, col declino definitivo della causa borbonica, il brigantaggio tornò a essere quello che era: un fenomeno criminale, non dissimile per molti aspetti dalla mafia rurale che iniziava ad emergere con forza in quegli anni.
L’avventura di Francesco II iniziò con la splendida resistenza di Gaeta e terminò con l’abbandono di Roma senza che gli ambienti borbonici riuscissero mai a incidere nelle dinamiche politiche del Sud. È sopravvissuto solo il mito del brigantaggio, di cui a un’attenta analisi resta ben poco. Per quel che riguarda il libro, ci fermiamo qui.
Giusto un’osservazione per concludere: il metodo aperto e intelligente di Pinto fornisce alcune suggestioni comparative.
Infatti, se è vero che le dinamiche del brigantaggio sono quelle della politicizzazione di un fenomeno criminale di massa, nulla vieta di trovare dei paragoni con fatti più recenti: viene in mente, ad esempio, la guerra civile della ex Jugoslavia, durante la quale gruppi paramilitari pieni zeppi di persone senz’altro non a posto con la legge (è il caso delle famigerate Tigri di Arkan, formatesi attorno agli ultrà della Stella Rossa Belgrado) si distinsero per le atrocità commesse in Bosnia e in altri teatri balcanici. Oppure altre, analoghe vicende, verificatesi nei territori dell’ex impero sovietico.
Ce n’è abbastanza per capire che la storia, certa storia, ha ancora troppe cose da insegnare. E allora, rileggiamola bene, prima di dar credito alle letture faziose di certo revisionismo che ha attecchito solo grazie alla grave crisi del sistema Italia e del Meridione in particolare.
La guerra per il Mezzogiorno è un esempio di come si deve raccontare questa storia, perché, ci si scusi il bisticcio, è storia raccontata come si deve: con imparzialità e passione, profondità e chiarezza.
Non è poco, in questi tempi di grande confusione.
27,466 total views, 8 views today




Ho avuto già modo di leggere alcuni scritti di Carmine Pinto (la dottrina Pallavicini) e credo che questo sia uno di quei libri da leggere. Cordialmente
Gli Stati Uniti nelle riserve si comportano meglio…..
Su quali basi lo afferma? Qui non siamo su Facebook. La prego, motivi meglio o vada a fare il troll altrove.
Saverio Paletta